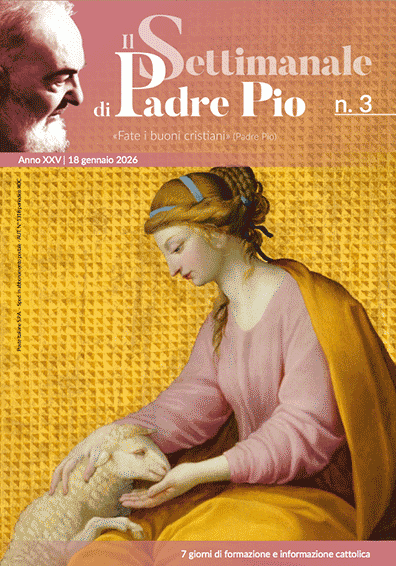La questione del fine
dal Numero 8 del 23 febbraio 2014
di Corrado Gnerre
Ognuno fa esperienza in se stesso del “senso dell’attesa”. Altro non è, in noi, che l’invocazione di un “fine” che dia senso e pieno appagamento al trascorrere del tempo su questa terra e ad ogni nostro desiderio che trascende il “qui e ora”.

In un precedente articolo abbiamo parlato del fatto che l’uomo vive in una condizione di evidente “attesa” ciò perché ha consapevolezza del trascorrere del tempo. Tale consapevolezza lo indirizza verso il dopo desiderando che il tempo stesso possa risolversi nell’eternità.
Una situazione di questo tipo pone due questioni. La prima è che l’attesa invoca logicamente un fine; la seconda è che l’attesa si configura come appagamento del desiderio.
Chiariamo, perché, dette così, le cose sembrano essere un po’ incomprensibili.
L’attesa invoca logicamente un fine
L’attesa che contraddistingue l’esistenza umana non è un’attesa senza senso. Questa non può appagare né tantomeno sarebbe ragionevole. È un’attesa che deve concludersi con qualcosa di reale, di talmente appagante che possa soddisfare pienamente l’esistere umano.
Il grande Giovannino Guareschi (1908-1968) ci offre una bella immagine. Eccola: «E fra mille anni la gente correrà a seimila chilometri l’ora su macchine a razzo superatomico e per far cosa? Per arrivare in fondo all’anno e rimanere a bocca aperta davanti allo stesso Bambinello di gesso che, una di queste sere, il compagno Peppone ha ripitturato col pennellino». Qui Guareschi unisce alcuni concetti importanti: il correre, l’uso di un progresso tecnologico sofisticatissimo e un desiderio che rimane inalterato nel tempo. È ciò che abbiamo detto in un precedente articolo: nell’uomo albergano dei bisogni che sono universali, che non cambieranno mai, malgrado possa cambiare (e cambia) il suo essere contestualmente nella storia.
L’attesa come appagamento del desiderio
Da qui la necessità dell’uomo di dare un significato al suo esistere, ma un significato che sappia davvero andare oltre il “qui e ora”, e che quindi sappia sfondare l’esistenza stessa.
C’è un’alternativa da cui non si può prescindere: o convincersi di venire dal nulla o convincersi di essere frutto di un progetto. Nel primo caso bisogna consequenzialmente convincersi di essere una sorta di “incidente di percorso”, e pertanto di essere “gettati nel mondo”. Nel secondo caso bisogna convincersi che la propria vita è stata pensata e voluta, che essa ha un senso e che il percorso vada realizzato nel riconoscimento di una “compagnia” (Dio) a cui corrispondere. L’alternativa è proprio questa, e da questa non si può prescindere. Se si opta per la prima convinzione, la vita si rivela come assurdo e come realtà che non può suscitare meraviglia, gusto, quasi come realtà nauseabonda.
La celebre astrofisica Margherita Hack (1922-2013), recentemente scomparsa, si è spesso impegnata (duole dirlo, ma è così) nell’attività di “cattiva maestra” diffondendo idee tutt’altro che conformi alla legge naturale. Ebbene, in uno dei suoi numerosissimi incontri con studenti scolastici ebbe a dire che il Big Bang può essere definito come «una grande scorreggia dell’universo». Frase disgustosa ma coerente. Se all’inizio non viene riconosciuto un progetto, un pensiero, un Logos, allora tutto è all’insegna dell’illogico, per cui non c’è né un giusto né un ingiusto, né un bene né un male, né un bello né un brutto... non c’è nemmeno la possibilità di distinguere il profumo dal cattivo odore.
Volendo aprire una parentesi sull’arte, non è un caso che due celebri opere di arte contemporanea riguardino l’orinare e il defecare: La fontana di Duchamp (1887-1968) del 1917 e Merda d’artista (sono costretto, ahimé, a riportare questa espressione perché è il titolo ufficiale dell’“opera”) di Piero Manzoni (1933-1963), del 1961. La prima è un semplice orinatoio, la seconda delle scatole di latta che conterrebbero le feci del sedicente “artista”.
Senza Significato, senza progetto, senza ragione, senza un Logos, la vita è un essere gettati nel mondo, per cui non c’è differenza tra un atto di amore o di odio, tra un’impresa eroica o un defecare o un orinare.
Senza Significato, ogni cosa che si fa, anche se meravigliosa, grande, utilissima, è priva di luce, cioè... è priva appunto di significato. La luce è ciò che illumina il reale, ovvero ciò che rende conoscibile la realtà che è posta dinanzi allo sguardo. Così come le cose esistono anche al buio, indipendentemente dall’essere illuminate o meno, parimenti tutto ciò che l’uomo compie o può compiere esiste anche se egli non ha inserito nella sua vita il fondamento... ma tutte queste cose, inevitabilmente, rimangono buie.
Scrive il grande scrittore inglese Thomas Stearns Eliot (1888-1965) a proposito del nostro tempo in cui vi è la pretesa di affermare che la vita dell’uomo non scaturisca da una ragione: «O buio, buio, buio. Tutti vanno verso il buio, / i vuoti spazi interstellari, il vuoto verso il vuoto, / i capitani, i grandi banchieri, gli eminenti letterati, / i generosi mecenati dell’arte, gli statisti e i sovrani, / distinti impiegati statali, presidenti di molti comitati, / industriali e piccoli mediatori, tutti vanno verso il buio. / È buio il sole e la luna, e l’almanacco di Gotha. / E la gazzetta della borsa, e il consiglio dei direttori, / e freddo il sentimento e perduto il motivo dell’azione. / E noi tutti andiamo insieme a loro, nel silenzio funerale, / funerale di nessuno, perché non c’è nessuno da seppellire».
Lo riconosce perfino Jean-Paul Sartre (1905-1980): «Dostoevsky ha scritto: “Se Dio non esiste tutto è permesso”. Ecco il punto di partenza dell’esistenzialismo. Effettivamente tutto è lecito se Dio non esiste, e di conseguenza l’uomo è “abbandonato” perché non trova né in sé né fuori di sé possibilità di ancorarsi [...]. Così non abbiamo né davanti a noi né dietro di noi, nel luminoso regno dei valori, giustificazioni o scuse. Siamo soli, senza scuse. Situazione che mi pare di poter caratterizzare dicendo che l’uomo è condannato ad essere libero. Condannato perché non si è creato da solo, e ciò non di meno libero perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto quanto fa [...]. L’uomo, senza appoggio né aiuto, è condannato in ogni momento a inventare l’uomo».
Quanto invece è diverso ciò che afferma san Tommaso d’Aquino (1225-1274) nella Summa Theologiæ (prima secundæ, questione 1, articolo 5): «Bisogna che il fine ultimo soddisfi talmente l’intero desiderio dell’uomo, cioè ogni sua esigenza e aspirazione, da non lasciare niente da desiderare e da ricercare all’infuori di esso».
San Tommaso parla di fine e di desiderio. La vita umana non può prescindere dal fine e questo non può che identificarsi con la realizzazione del desiderio. Etimologicamente “desiderio” vuol dire “mancanza delle stelle” (de-sidera), ciò vuol dire che il vero desiderio (ed è a questo che si riferisce san Tommaso) non è un aspirare a qualcosa di transitorio, di passeggero, di terreno, bensì di alto, di altissimo: è un desiderare le stelle, è un desiderare l’assoluto, è un desiderare Dio.
- 1 La Medaglia miracolosa: umile strumento per risvegliare la fede
- 2 Padre Matteo e l’Intronizzazione del Sacro Cuore
- 3 Come padre Pio si preparava al Natale?
- 4 Il nuovo anno nell’augurio di San Pio
- 5 I soldati di Cristo Re
- 6 Maria Mediatrice di tutte le grazie nella Divina Commedia
- 7 10 dicembre 1925: un centenario da non dimenticare
- 8 Il mistero dell’Immacolata Concezione e della Corredentrice