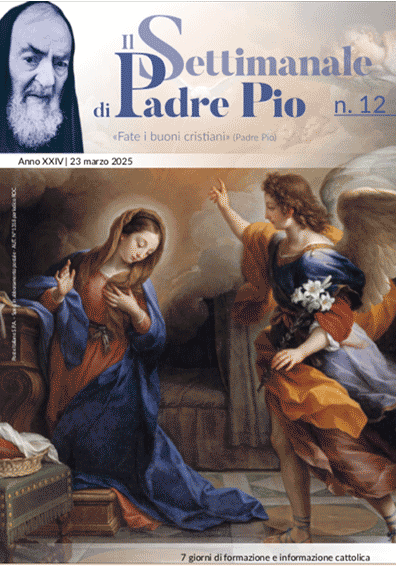Padre Pellegrino racconta: le avventure di un pomeriggio / 2
dal Numero 6 del 9 febbraio 2020

Era stato padre Pio che, vedendomi fermo dinanzi alla porta e notando nel mio volto lo sconvolgimento provocato dal cattivo comportamento, mi aveva invitato ad entrare. E una volta entrato avevo creduto di distrarmi e di distendermi, ascoltando la conversazione del terzetto. Ora mi vedevo completamente scoperto nel mio disperato bisogno di aiuto ed esposto alla meritata derisione. Padre Pio però, anche quando nell’esprimere un parere aveva impiegata tutta la spietatezza del proprio rigore, teneva sempre pronto un pizzico della propria “divina” umanità. Molto sorprendentemente, ma anche molto opportunamente per me, parafrasò una espressione di san Paolo: «Del resto chi è debole e io non lo sono? chi è disperato e io non lo sono? chi è cattivo e io non lo sono?».
Fuori la lettera!
Come a qualsiasi altro uomo si era paragonato anche a me, non senza un pizzico di “santa malizia”, nella speranza cioè d’indurre me a fare la stessa riflessione nei confronti del signore milanese. Ed io effettivamente avrei voluto avere la sua stessa comprensione e solidarietà verso tutti i fratelli per portarmi al livello di qualsiasi essere umano, ma non ci riuscivo. Mi sentivo come schiacciato e paralizzato su quella specie di sedia spinosa e stretta che avevo sotto di me. Allo scopo di darmi un contegno, mi tenevo eretto sul busto, e nuotavo in un bagno di sudore, non tanto per lo sforzo di voler arrivare, secondo la mia misura, all’altezza di padre Pio, quanto per l’inutilità dello stesso sforzo: in pratica mi sentivo incapace di arrivare alla vera comprensione, sia quando venivo lasciato in pace, sia quando venivo spinto con l’esempio e con le parole.
Padre Pio poggiandosi sui braccioli della poltrona si alzò per dire all’orecchio del signor Testa: «Ho perduto la pazienza con questo “cocciuto”: puoi prestarmene un poco tu?». Compreso o incompreso da me come dagli altri, riattizzava il fuoco della familiare conversazione con frasi piccanti ed eccitanti senza abbandonare l’intenzione di aiutarmi. Finalmente girò verso di me un volto ancora coperto dai veli del rigore, ma già illuminato dalla fiamma della carità. Mi disse: «Caccia ‘ssa lettera!» (Tira fuori questa lettera!). Incoraggiato ormai e invitato da lui, vinsi, non senza qualche lacrima, la vergogna: trassi fuori dalla pettorina la lettera e gliela porsi.
Con la lettera egli afferrò anche la mia mano, dandomi l’impressione di afferrarmi l’anima e di strizzarmela con una stretta troppo forte per la sua mano piagata, e, con il piacere di trovare il pane per i propri denti, commentò: «Come sono dure queste quattro ossa!».
Presa l’iniziativa di aiutarmi a riparare il male fatto, non si sarebbe fermato neppure se mi avesse visto stanco morto. Sempre tenendomi per mano, si accomodò nuovamente sulla poltrona. Avrei voluto compiere un gesto di disperato, sincero e un po’ teatrale pentimento, buttandomi in ginocchio davanti a lui, senza badare minimamente alla presenza degli ospiti. Ma fallii anche in questo supremo sforzo: cadendo battei la fronte sul suo ginocchio e se non lo ridussi a pezzi, fu perché lo trovai duro almeno quanto la mia testa. Avvilito per l’ennesimo fallimento dei miei nobili sforzi penitenziali, convinto di dover urgentemente rafforzare non tanto la scatola cranica quanto la materia grigia in essa contenuta, gli chiesi subito scusa. Il caro Padre, supponendo giunto il momento di una mia spettacolare Confessione, aveva già fatto cenno agli amici di lasciarci soli; ma non era servita a niente la delicata precauzione. Gli amici potevano rimanere. Per sommo di delicatezza seppe mascherare il dolore della botta. Si stropicciava il ginocchio come se stesse stirando il saio. Poi mi disse sorridendo: «Figlio mio, e di che vuoi scusarti? Accetta intanto i miei complimenti: tu con le tue capocciate saresti capace di atterrare qualche pilastro della chiesa».
Il signor Testa, grassottello, ma agilissimo, giustamente preoccupato del ginocchio ammaccato, saltò in piedi e cercò freneticamente nelle tasche una pomata anti-spasmo, non volendo lasciarsi sfuggire l’occasione di fare qualcosa per padre Pio. Il Padre lo calmò: «L’unguento adatto per le parti colpite da certi capoccioni non può stare nelle tue tasche: lascia perdere». Poi, indicando me al signor Testa, aggiunse con un sorriso malizioso: «Dottore, non è il mio ginocchio che ha bisogno di cure, ma la testa di questo qui; anzi questo qui puoi curarlo solo tu, e io te lo affido». Il signor Testa aveva dovuto fare la faccia tosta con tante persone per giungere nel salottino di padre Pio, aveva dovuto assistere a una gelida conversazioncina fatta di provocazioni e di rimproveri, ma ora finalmente si era guadagnata la giornata con l’offerta di un paziente: il signor Testa era un veterinario.
Votato alla mia salvezza
Padre Pio, riammorbidito un poco e più disposto all’indulgenza, ma ancora un tantino severo, intento, anche nel salottino, quasi come in chiesa, ad esaurire il numero delle proprie preghiere e devozioni, si dimostrava capace nello stesso tempo di saper pensare con carità agli altri, come a se stesso e più che a se stesso; generoso figlio di una razza buona e sincera, si confermava, nella potenza dei fatti, uomo di grande cuore e apriva uno spiraglio di luce nei miei tempestosi sentimenti e vi metteva un po’ d’ordine. Votato “ostinatamente e pazzamente” alla salvezza delle anime, sognava certamente di restituirmi, nella integrità della mente e della grazia, in una miracolosa rinascita, a me stesso e al mio lavoro. Sulle sue labbra balenava, di tanto in tanto, un sorriso, ma non quello consueto: era il sorriso un po’ amaro di chi si prendeva l’impegno di riparare al male fatto dal confratello e se lo prendeva con tanto zelo da apparire lui il colpevole o, almeno, il corresponsabile dell’accaduto.
Gli amici presenti ignoravano il “mio” fattaccio e, dando ragione a padre Pio, si ponevano degli interrogativi molto seri sulla mia condotta, ma se ne ponevano qualcuno anche sull’eccesso di rigore del santo Frate. Padre Pio, lieto di non essere costretto ad espormi al ludibrio totale, giocava appunto sui loro dubbi e le loro incertezze, ma non poteva fare a meno di pungermi e graffiarmi, per ricavare qualche frutto dalla mia buona volontà.
Il mare di dolore
Nel leggere la lettera, scritta con un carattere nervoso e macchiata di lacrime da quel padre infelice e vicino alla pazzia, il Padre spirituale, che sembrava avesse indossato, per l’occasione, la toga più nera di tutti i tribunali del mondo, mi manifestava, nella tristezza del volto, un tumultuoso disgusto per la risposta sgarbata da me data al signore milanese. Da parte mia, nell’aria ancora greve, avvertivo già il profumo del perdono e mi stavo avviando a un sincero pentimento, per mettere, con un’intima, ma solenne liturgia penitenziale, una pietra tombale sul fattaccio. Tuttavia, anche in un momento così drammatico, cercavo scuse per il mio operato e, appena credevo di aver scoperto, nel torbido del mio cervello, qualche stupido cavillo, non sapevo fare a meno di tirarlo fuori: «Quel signore fa una grande pena; però a me pare che affoghi in un bicchiere d’acqua». Per la stupidità delle mie parole, divorato dentro dal fuoco dell’ira di Dio, ebbe, nel volto, una vampata di fuoco; con il lampo sfuggito dai suoi occhi, raccomandò tacitamente proprio a me di “mantenerlo”, perché non avrebbe voluto precipitarsi su di me e dirmi “quattro parole verdi”. Si dominò. Finì di leggere la lettera con le lacrime agli occhi e poi disse con calma: «Uagliò, ma tu stasera ragioni con i piedi o con la testa? Un uomo che ha perduto tragicamente la figlia affoga in un bicchiere d’acqua?! Questo povero uomo affoga, sì, ma in un mare di dolore! Sei tu che affoghi in un bicchiere d’acqua, quando ti avvilisci per gli incidentucci dell’ufficio di prenotazione. E poi chi ti ha detto che la tua compassione puoi offrirla a chi ti sembra che soffra molto e negarla a chi ti sembra che soffra poco?».
Sapevo di avere torto marcio, ma, con i miei cavillosi pretesti verbali, speravo di assaporare il conforto di qualche piccola attenuante generica, per cui alla sua risposta rimasi senza fiato, come pugnalato. Nonostante questo, ebbi tuttavia la forza di ripescare il conforto non giunto da lui in un altro giudizio dispettoso, crudele e sciocco: «Ma io voglio soltanto dire che proprio nei grandi dolori dobbiamo dare prova delle nostre capacità di superamento». Provvisto di gentili e sane risorse, padre Pio gustava al massimo la gioia e la bellezza d’intrattenersi amorevolmente con un fratello caduto e, nello stesso tempo, deciso a pagare il prezzo del risollevamento, e non si tirava indietro né per seccatura, né per rispetto umano, di fronte all’apparente banalità dell’operazione. Rispose con santa pazienza: «Io giudicherei la cosa diversamente: questo uomo è capitato a San Giovanni Rotando per me e ringrazio il Signore che dà a me, strumento indegno, la possibilità di risollevare un’anima; ma il Signore lo aveva posto anche sul tuo cammino, perché tu dessi prova di bontà d’animo, e invece hai dato soltanto prova di grettezza e di cattiveria».
Non era quello, un pomeriggio distensivo per nessuno e molto meno per me. Mi parve che una figlia l’avesse perduta tragicamente padre Pio in persona, tanto si era immedesimato nel dolore del signore di Milano. Inoltre, mi sembrava, in quel momento, un padre che stesse perdendo in me un altro figlio per la galera; ma era certamente disposto a pagare per noi, quasi fosse lui il responsabile di tutte le disgrazie.
Puntò contro di me l’indice della mano destra e mi disse una cosa terribile: «Tu sai che io benedico sempre tutti, di notte e di giorno, anche quando, non vedendone chiaramente la conferma da parte di Dio, non so dove appiccicare la benedizione; stasera però ho sentito un impulso fortissimo a lanciare su di te, nel nome di Dio, una maledizione e non perché hai maltrattato il signore milanese, ma perché hai creduto di avere il diritto di maltrattarlo per il fatto che in quel momento soffrivi anche tu. Capisco il tuo stato d’animo. Però quello che, secondo te, è una scusante, è, secondo me, un aggravante. La tua sofferenza non ti dispensa dal consolare gli altri, ma ti obbliga di più». Con queste parole mi fece comprendere perché egli fosse così comprensivo verso tutti i sofferenti, buoni e cattivi, coraggiosi e vili: quanto più soffriva, tanto più s’imponeva di comprendere gli altri; quanto più soffriva, tanto più riusciva a consolare gli altri e a dimenticare se stesso.
Ordinariamente non posava per alcun fotografo, ma quella sera, pregato dagli amici, acconsentì con grazia a farsi fotografare, stando in piedi, incorniciato nel vano della finestra; poi disse agli amici che avrebbe pregato per le loro famiglie, li benedisse, si lasciò baciare ripetutamente la mano. Infine li pregò: «Avrete tutta la mia gratitudine, se ora mi lasciate libero». Gli amici andarono via, non so se più compassionevoli o più invidiosi verso di me, ed io rimasi a sorbirmi il finale della strigliata. (CONTINUA)
Padre Pellegrino Funicelli,
Padre Pio tra sandali e cappuccio,
pp. 199-205
- 1 Padre Stefano M. Manelli: 70 anni di luminoso Sacerdozio al servizio di Dio e della Chiesa
- 2 Il miracolo che toccò a Lea Padovani
- 3 Il Battesimo di desiderio per i bambini non nati: che cosa dice la Chiesa cattolica
- 4 L'arma invincibile di padre Pio
- 5 San Lorenzo da Brindisi, missionario fra gli eretici
- 6 Il Purgatorio e Maria Santissima
- 7 Il segreto per essere Santi
- 8 Ecco sette veri Frati Minori