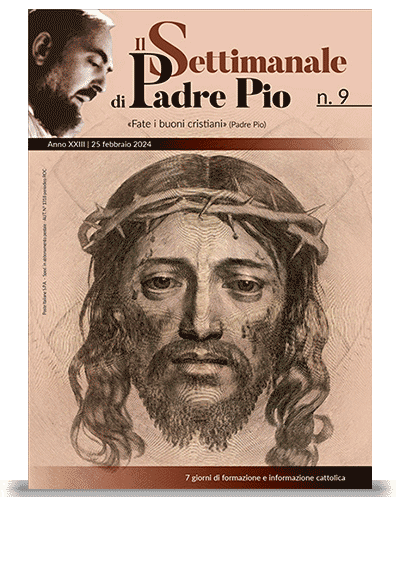Santità e carità non si improvvisano. 80 anni fa il martirio di san Massimiliano
dal Numero 30 del 15 agosto 2021
di Suor M. Elisabetta Daniello, FI
La statura morale di san Massimiliano è giustamente misurata e segnata dalla scelta di poter morire al posto di un padre di famiglia nel campo di sterminio. Ma questo eroico martirio è il traguardo di una “corsa nella carità” iniziata molto prima e durata tutta la vita. Vediamo come anche nel campo, prima dell’ora suprema, la sua carità si irradiasse in modo costante, multiforme, luminoso.

Ogni gesto nobile ed eroico trova la sua scaturigine in una ferma volontà, la quale è mossa da una forte motivazione o da un ideale più alto che spinge a perseguirlo anche a costo del sacrificio di sé. Da ciò ne deriva che la virtù eroica non può essere improvvisata, e così anche l’atto più nobile qual è quello del martirio, difficilmente sarà un atto improvvisato o lasciato al caso, ma generalmente sarà il risultato di continue rinunce a se stessi, fino a fare del sacrificio e della rinuncia un abito virtuoso.
Quest’anno, il 14 agosto, ricordiamo l’80° anniversario (1941-2021) dello straordinario ed unico martirio di carità di san Massimiliano M. Kolbe, il fondatore delle due Città dell’Immacolata, una in Polonia e l’altra in Giappone.
Egli si offrì volontariamente a morire nel bunker della fame del campo di concentramento di Auschwitz al posto di un padre di famiglia, e ciò lo associò in modo particolare a Gesù, Martire divino che offrì la sua vita sulla Croce per noi suoi fratelli.
La falsa accusa presentata per arrestarlo era quella di nutrire odio contro gli occupanti nazisti e fomentare un tale sentimento, unito a ribellione, anche in tutti i membri di Niepokalanów, la comunità di frati più numerosa del mondo.
L’odio voleva sopprimere l’amore, quell’amore che aveva sempre regnato nel cuore di padre Kolbe: amore per Dio, per l’Immacolata, per le anime (quelle dei confratelli come quelle di tutto il mondo), un amore custodito sempre gelosamente nel suo cuore, che nemmeno nel campo dell’odio e dello sterminio gli poterono strappare. Egli, infatti, aveva sempre amato “a proprie spese”, ossia a prezzo del sacrificio personale, persino i suoi nemici o i confratelli contrari al suo apostolato mariano volto alla conquista del mondo intero all’Immacolata. Quella carità che aveva praticato nelle situazioni ordinarie della vita ha continuato a praticarla anche ad Auschwitz, nel campo dello sterminio dove regnava l’odio: in quel campo egli dimostrò quanto fosse reale e consistente la sua carità teologale!
Arrivò nel campo alla fine di maggio, con un convoglio di prigionieri provenienti da Varsavia. Già durante il viaggio, fatto su vagoni merci per animali, aveva cercato di sollevare l’animo dei suoi compagni intonando canti religiosi, soprattutto mariani, per alleviare la pena interiore, giacché ogni polacco ben sapeva che partire per Auschwitz significava andare a morte sicura.
Assegnato al blocco dei sacerdoti e religiosi, era stato designato con gli altri a lavori massacranti che avrebbero presto esaurito le loro forze. I tedeschi lo facevano apposta, per sbarazzarsi al più presto dei sacerdoti e dei religiosi, da loro considerati “parassiti della società”.
Padre Kolbe guardava dritto negli occhi i suoi aguzzini, con uno sguardo di misericordia e pietà; ciò irritava molto quegli uomini crudeli, e così un giorno il comandante Fritsch decise di farla finita con il numero 16670 (numero con cui era identificato padre Massimiliano nel campo). Lo caricò di un’enorme quantità di rami, di molto superiore alle sue forze, e gli ordinò di correre. Rimanendo schiacciato dal peso, egli cadde a terra e come punizione fu battuto con 50 colpi da un assistente molto vigoroso. Lasciato a terra sfinito e creduto morto, lo aveva fatto gettare nel fango e coprire di rami. A sera fu riportato alla base in uno stato pietoso dagli altri prigionieri, e poi destinato all’ospedale del campo. Qui, più che trovare ristoro, avrebbe esercitato la sua carità aiutando i suoi fratelli più bisognosi, ossia i malati. L’ospedale versava in una condizione spaventosa: non esisteva alcuna norma igienica, vi aleggiava un fetore nauseabondo, in uno stesso letto trovava posto più di un malato e i pazienti vivevano nel costante terrore di una selezione che avrebbe destinato i più alla morte nelle camere a gas.
Angelo di carità
Padre Kolbe aveva sempre incoraggiato i suoi compagni di sventura e avuto sguardi di misericordia per gli autori di tante sofferenze. Si presentò all’ospedale sereno, con un sorriso di perdono, nonostante la vicenda del giorno precedente. Nonostante la febbre alta, la faccia livida per le percosse, gli occhi annebbiati, si mostrava incredibilmente paziente e sereno, e questo suo comportamento destava la meraviglia dei medici e degli infermieri, e lo stupore degli altri ammalati. Fu sistemato vicino alla porta della sala, il posto più scomodo, che nessuno voleva per sé. Lui invece, per il suo amore verso il prossimo, ne era contento, perché vi trovava un’occasione per praticare la carità: molti infatti a sera potevano andare da lui, strisciando fino al suo letto, per raccontargli le atrocità e i maltrattamenti subiti. Padre Massimiliano li consolava, se li stringeva al petto così come avrebbe fatto la più amorevole delle madri con il suo bambino spaventato. Alcuni gli confidavano che avrebbero voluto buttarsi sul filo spinato e farla finita con tanta sofferenza, ma egli li dissuadeva con così tanta dolcezza che quelli desistevano; altri gli chiedevano di ascoltare la loro Confessione, gli aprivano la loro anima e ricevevano l’assoluzione. Ed ogni volta era un rischio che lui non esitava di correre, ma se lo avessero visto le guardie, avrebbe ricevuto severe punizioni. Questo eroico confessore ripeteva ai suoi compagni di sventura: «L’amore è forza creatrice: solo l’amore crea!».
A don Corrado Szweda, sacerdote pallottino che svolgeva la funzione di infermiere e andava da lui a sera abbattuto e scoraggiato, una volta disse: «Come un bambino con gli occhi chiusi quando la mamma lo tiene per mano, così tu devi essere sereno, perché la Mamma Celeste ti tiene per mano». Le sue parole erano olio sulle ferite dei fratelli prigionieri, perciò essi ricorrevano spesso al “piccolo Padre”, come lo chiamavano, per essere rincuorati.
Egli svolgeva il suo apostolato nel campo non solo con la parola, ma anche con l’esempio. Se tutti i prigionieri cercavano d’istinto di procurarsi quanto potevano per migliorare anche di poco le loro condizioni e sopravvivere, padre Kolbe al contrario sceglieva per sé le cose peggiori, lasciando le migliori agli altri. Nell’ospedale c’erano i letti a più livelli e i malati cercavano quelli vicini alla finestra o quelli più in alto per evadere da afa e tanfo. Il “piccolo Padre” se ne stava sempre tranquillo ai letti inferiori e vicino alla porta, mentre gli altri malati, appena si liberava un letto vicino alla finestra, litigavano per accaparrarselo.
Don Szweda, avendo osservato l’abnegazione di padre Massimiliano, gli propose di sua iniziativa un posto ad un letto più in alto, ma questi gli fece notare che c’erano altri che ne avevano più bisogno di lui – eppure non dimentichiamo che egli era malato di tubercolosi e viveva con un solo polmone, per giunta malato – e disse: «E poi da qui posso benedire le salme che vengono condotte al crematorio».
Un’altra volta lo stesso don Szweda gli portò una tazza di tè; anche questa volta padre Massimiliano indicò un altro malato che ne aveva bisogno. «Perché fa così? Si indebolirà!», ribatté Szweda. «Sono forte e tutto posso in Colui che mi dà forza», rispose l’eroico francescano.
Nel campo si soffriva molto la fame e per poter avere qualche “briciola” in più si era disposti veramente a tutto: la fame era più forte di qualunque ragione!
Anche san Massimiliano sapeva cosa significasse soffrire la fame nel campo, ma riusciva a dominare il suo naturale istinto e sapeva donare agli altri la sua già piccola razione di cibo. All’ospedale ogni malato cercava di essere il primo o tra i primi della fila per ricevere la minestra, per averne di più. Riferiscono i testimoni che padre Massimiliano vi andava per ultimo, e quando la minestra era poca e al suo turno era già finita, rimaneva senza e non proferiva alcuna parola di lamento, né accusava alcuno. Quando nel campo a volte la zuppa era letteralmente solo “acqua”, non essendoci nulla di consistente se non nel fondo della pentola, allora egli andava per primo, per ricevere solo “acqua” e così lasciare agli altri fratelli prigionieri la parte più densa. Oppure capitava che rimanesse ancora zuppa nel pentolone e si distribuisse una seconda porzione; molti allora si accalcavano, spingendosi e strattonandosi per riceverla. Padre Massimiliano non si avvicinò mai per la seconda razione. Don Szweda gli chiese perché non si avvicinasse per ricevere altra zuppa, ed egli: «Ci sono quelli che hanno più fame di me!». Questa volta non nascose di patire anch’egli la fame, ma pensava a quelli che erano più affamati di lui. Se gli veniva portato del cibo che era avanzato, padre Kolbe lo dava subito a qualche vicino, mai una volta che pensò a sé!
Anche per il pane, all’ospedale, veniva fatto un tipo di sorteggio per decidere a chi toccassero le fette più grandi; egli non vi prese mai parte, indifferente per qualunque fetta gli toccasse, anche se più piccola.
Tali esempi a qualcuno forse potrebbero sembrare inezie, ma inseriti nel contesto della vita nel campo di sterminio, dove ogni giorno si lottava per vivere e sopravvivere, hanno dell’eroismo e infatti suscitavano l’ammirazione di chi li notava.
L’ora del martirio
Forgiato in questo continuo dominio di sé, tale da sembrare che non sapesse più pensare alla sua persona, si giunse alla fine di luglio 1941. Un prigioniero era fuggito dal blocco 14 – quello a cui apparteneva anche padre Massimiliano M. Kolbe, n. 16670 – e non era stato ritrovato. Questo significava che dieci prigionieri sarebbero stati sacrificati morendo nel bunker della fame. I poveri prigionieri ben sapevano cosa significasse vivere con la fame, e ora avrebbero sperimentato cosa significasse morire di fame. Fritsch scelse le sue dieci vittime; il 16670 non era stato menzionato, poteva tirare un sospiro di sollievo, ma udì il lamento di uno dei condannati, Francesco Gajowniczek: «Ah, mia povera sposa, miei poveri figli, ormai orfani del vostro padre!». A padre Massimiliano sembrò che quelle parole sfiorassero la disperazione, non poteva abbandonare quei dieci fratelli a morire da disperati; eccolo uscire dalla fila, farsi avanti – egli sapeva di rischiare la morte anche solo per questo –, togliersi il berretto da prigioniero e con molta umiltà e fermezza far richiesta di sostituire “quel prigioniero”, indicando Gajowniczek. Il Comandante avrebbe anche potuto semplicemente aggiungerlo ai dieci, dato che aveva tanta fretta di morire, e invece no. Chiese chi fosse, e perché volesse farlo: «Sono un sacerdote cattolico, sono vecchio e solo, la mia vita non è utile come la sua che ha famiglia. Chiedo che gli sia data la possibilità di vivere. Voglio morire al suo posto».
Disse di essere vecchio, ma aveva solo 47 anni; di essere solo, ma aveva circa 800 frati che lo consideravano più che un padre e aspettavano che tornasse a Niepokalanów, la Città dell’Immacolata; lo amavano al punto che, dopo il suo arresto, si offrirono in dieci, e tra i più giovani, per prendere il suo posto in carcere, facendosi carico delle sue accuse e della sua pena. Il Padre provinciale, ricevendo tale richiesta, ne era rimasto commosso: padre Massimiliano M. Kolbe in breve tempo aveva formato questi giovani frati rendendoli uomini capaci di un tale atto eroico; tanto era l’amore che da questo Padre avevano ricevuto, da volerlo salvare, dimostrandogli quanto anche loro lo amassero in Dio e desiderassero che tornasse a guidare l’opera della Città dell’Immacolata a favore delle anime.
Fatto incredibile: il Comandante accettò la richiesta, Kolbe prendeva il posto di Gajowniczek, il quale, benché uscito vivo dal campo di concentramento, non rivide più i due suoi figli.
I dieci condannati furono condotti nel blocco dove erano le celle loro destinate. Non mangiavano dal pranzo del giorno precedente ed erano sfiniti dopo la giornata trascorsa sull’attenti e sotto il sole cocente di luglio. Alcuni per questo barcollavano e padre Massimiliano ne sorreggeva uno, aiutandolo a raggiungere la cella. Qui iniziò il suo lavoro di buon samaritano, per accompagnare alla soglia dell’eternità questi nove innocenti condannati a morte dalla perfidia umana, e non solo loro, ma anche quelli delle celle adiacenti che si trovavano là a causa di fughe precedenti.
Le preghiere e i canti religiosi che padre Massimiliano innalzava, echeggiavano in queste novelle catacombe. Lui che, a Niepokalanów, aveva destinato ogni primo venerdì del mese alla pratica dell’esercizio della buona morte, ora si trovava a preparare se stesso e i suoi compagni a questo estremo passo. Il suo gesto a qualcuno è parso un fuggire e abbreviare la sofferenza, quasi un suicidio; in realtà fu il coronamento della sua vita, la quale era stata sempre “dono per gli altri”; la piena realizzazione del suo anelito, espresso nell’intenzione della Santa Messa del suo primo Natale come sacerdote: «Pro amore usque ad victimam” (dal Diario delle Messe).
La carità che aveva esercitato nei suoi conventi, in patria come in missione, con tutti i confratelli, anche quelli difficili o che gli erano in certo senso avversari, ora lo stava consumando. Egli dimostrava piena conformità al Maestro divino che aveva detto: «Non c’è amore più grande di chi offre la vita per i suoi amici». Nel terribile campo di Auschwitz, questa fu una vittoria dell’amore. Grazie, san Massimiliano, per averci dato l’esempio dell’amore più eroico!
- 1 2 febbraio: La Candelora
- 2 Nostra Signora del Buon Successo Profezie e speranze per i giorni nostri
- 3 Fiducia supplicans: benedizioni alle coppie gay
- 4 Benedizioni anonime e anomale | Su Fiducia supplicans
- 5 Il metodo educativo di don Bosco e quello di don Milani
- 6 Quaresima: opportunità per diventare veri “figli della luce”
- 7 Fatima e la penitenza marianizzata
- 8 Santa Quaresima con la Madonna