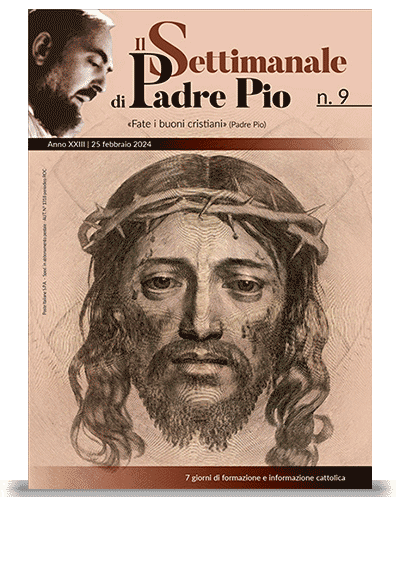Io mi chiamo Joseph
dal Numero 1 del 3 gennaio 2021
di Maurizio Brunetti
Una storia di straordinaria ordinarietà, in cui l’onda di male che sommerge le nostre città si infrange sugli scogli dell’ostinata volontà di bene che vive nelle persone semplici.

Silvana De Mari è una scrittrice di talento. Mi piace ricordarlo d’esordio in tempi in cui il suo nome è forse più noto ai lettori per la limpida e coraggiosa testimonianza che ella compie, giorno dopo giorno, contro la dittatura del politicamente corretto. Le sue prese di posizione – “spietate” agli occhi degli avversari e di un certo mondo cattolico tiepido e accomodante, semplicemente “risolute e senza complessi” agli occhi di chi invece la ammira — hanno un loro prezzo in termini di «presentabilità sociale» e non solo; ma la scrittrice, evidentemente, non ritiene tale prezzo sufficientemente alto da smettere di «vivere senza menzogna», probabilmente convinta, come disse il grande scrittore russo e premio Nobel per la letteratura Aleksandr Solgenitsin (1918-2008), che «una sola parola di verità pesa più dell’intero universo».
Certo, sull’aletta di copertina di uno dei suoi molti libri apprendiamo che l’autrice, specializzata in chirurgia generale e psicologia cognitiva, preferisce non definirsi una scrittrice, ma un medico che scrive. È bene, comunque, che il lettore sappia che stiamo parlando di un vero e proprio «caso letterario»: un’autrice tradotta in una ventina di lingue, ritenuta tra gli esponenti più autorevoli e letti della letteratura fantasy italiana.
Il romanzo Io mi chiamo Joseph (Ares 2018, pp. 160) è a prima vista atipico rispetto al resto della produzione della De Mari, perché ambientato in una città italiana del nostro presente: niente spade scintillanti, né creature fantastiche, quindi; non c’è neanche spazio per il fantastico «gatto dagli occhi d’oro» che dà una curvatura favolistica al romanzo omonimo, quest’ultimo catalogabile, in realtà, tra i «romanzi di denuncia» accennando, sia pure in uno stile che lo rende adatto anche a un pubblico adolescenziale, alla pratica atroce dell’infibulazione cui sono soggette (in Italia!) ragazzine appartenenti a minoranze afro-arabe.
De Il gatto dagli occhi d’oro (Fanucci 2009 e poi Giunti 2015), Io mi chiamo Joseph è una sorta di séguito, e certamente la scrittrice si è divertita a costruire la seconda storia inserendo parallelismi strutturali: al di là dell’analoga collocazione spazio-temporale e il ritrovare nell’uno molti personaggi presenti nell’altro, in entrambi c’è un adolescente da salvare e un basset-hound, un cane bassotto che innesca il motore narrativo.
Il Joseph del titolo è un quattordicenne metà senegalese e metà nigeriano che, nelle prime pagine del romanzo, conduce un’esistenza solitaria vivendo di piccoli furti. È arrivato clandestinamente in Italia nel 2011 ed è un sopravvissuto: tutti i suoi parenti più stretti sono stati uccisi l’anno precedente nel massacro di Dogo Nahava. Tale eccidio, purtroppo, non è esistito solo nella fantasia della scrittrice: il 7 marzo 2010, di primo mattino, musulmani appartenenti all’etnia Fulani e Huasa irruppero in questo e altri villaggi della Nigeria centrale uccidendo a colpi di machete quanti più abitanti possibili e bruciando vivi quelli che erano rimasti all’interno delle loro case. Persero così la vita 500 persone, uomini, donne e bambini. Dai microfoni di Radio Vaticana monsignor John Olorunfemi Onaiyekan ci tenne a precisare che non si era trattato di «un conflitto religioso, ma etnico», eppure le vittime furono pressoché tutte cristiane. Infatti, secondo quanto pubblicato dai media – in Italia, in particolare, dal quotidiano Avvenire –, 48 ore prima dell’attacco qualcuno era stato così cortese da far pervenire un messaggio sui cellulari dei musulmani residenti in quei luoghi con il quale si consigliava loro di cambiare aria per qualche giorno…
Il ragazzo che incontriamo nelle prime pagine è, dunque, un ragazzo lacerato e senza speranza. È sopravvissuto al massacro ed è riuscito ad arrivare fortunosamente in Italia, ma solo per sperimentare gli abusi e i maltrattamenti cui sono ordinariamente soggetti molti dei bimbi che approdano in Italia senza documenti, spesso costretti all’accattonaggio forzato in condizioni, di fatto, schiavistiche. Ed è questo il primo salutare cazzotto che raggiunge il lettore, magari convinto di «fare la cosa giusta» quando guarda con favore a politiche migratorie di apertura indiscriminata delle frontiere, senza però accorgersi che vi sono molti circuiti criminali – tanto nei Paesi di provenienza, quanto in quelli di transito e in quelli di approdo – che ne trarranno vantaggio ai danni proprio dei più deboli e più indifesi.
Ed è per questo che – dicevamo – questo romanzo è solo apparentemente estraneo all’epica fantasy, il genere nel quale la De Mari ha dimostrato una particolare maestria. Gli orchi operano anche in Io mi chiamo Joseph: la loro mostruosità è probabilmente solo interiore, ma faranno comunque di tutto perché i bambini di cui abitualmente abusano, gli innocenti che comprano, vendono, uccidono e smembrano, non sfuggano alle loro grinfie.
Sulla trama non vorremmo dire molto altro, se non che a Joseph verrà data una possibilità per ritrovare se stesso e conquistarsi quel tanto di felicità possibile in hac lacrimarum valle.
Tra i punti di forza del romanzo, vi è la verosimiglianza dell’evoluzione psicologica del protagonista (e qui certamente l’autrice mette a frutto la sua esperienza di psicoterapeuta). Il veterinario di buon cuore che per primo si prende cura di Joseph – una sorta di hobbit, ma di grandi dimensioni, trapiantato nel mondo reale – gli proporrà a mo’ di terapia un percorso cinematografico anti-relativista, una selezione di film con Clint Eastwood, dove i buoni – con buona pace dei soloni liberal e progressisti – possono persino usare le pistole d’ordinanza contro i cattivi!
Vi sono, inoltre, pagine di assolto lirismo – luminose oserei dire –, come il «quadretto» descritto nel capitolo intitolato Caldarroste, in cui «il ragazzo nero e la ragazzina d’oro» siedono sulle scale di una chiesa «alla luce dei lampioni e delle decorazioni di Natale», con accanto una cagnolina festante.
Dicevamo che nel libro non mancano gli orchi, ma neanche manca una figura elfica – o dovrei dire angelica? – incarnata in un misterioso bambino con la maglietta a righe blu e verdi e i pantaloncini gialli che compare nel romanzo quando tutto per i buoni sembra perduto.
La religione viene nell’intreccio evocata solo di striscio (cosa che John R. R. Tolkien avrebbe senz’altro apprezzato), ma questa storia – terribilmente realistica, intendiamoci – una morale «cattolica» ce l’ha e mi arrischio a riassumerla in questi termini: nel più abietto dei mondi e delle situazioni possibili, non sono solo i pazzi ad aver ragione di sperare, perché – grazie a Dio – non esiste in questa vita dolore che non possa essere consolato.
- 1 2 febbraio: La Candelora
- 2 Nostra Signora del Buon Successo Profezie e speranze per i giorni nostri
- 3 Fiducia supplicans: benedizioni alle coppie gay
- 4 Benedizioni anonime e anomale | Su Fiducia supplicans
- 5 Il metodo educativo di don Bosco e quello di don Milani
- 6 Quaresima: opportunità per diventare veri “figli della luce”
- 7 Fatima e la penitenza marianizzata
- 8 Santa Quaresima con la Madonna